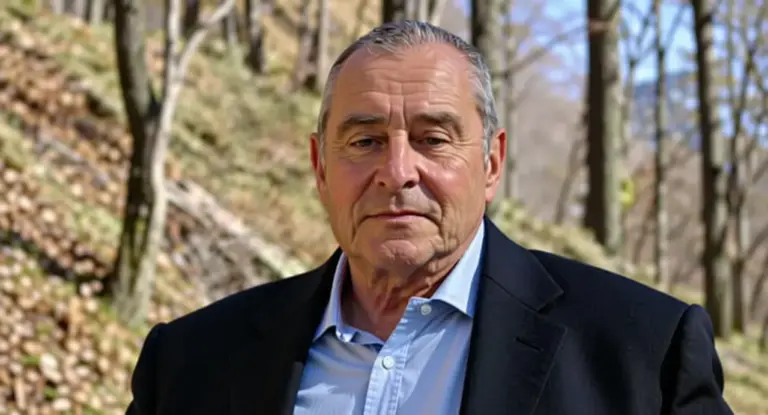Scalare la montagna più alta del mondo non è soltanto una questione di forza fisica: rappresenta una sfida ai confini stessi della fisiologia umana. L’Everest, con i suoi 8.848 metri di altitudine, pone il corpo umano in condizioni estreme dove l’ossigeno disponibile è insufficiente per la sopravvivenza prolungata. Fino agli anni Settanta, la comunità scientifica riteneva impossibile raggiungere la vetta senza respiratori artificiali. Eppure, l’8 maggio 1978, due scalatori dimostrarono che i limiti dichiarati dalla scienza potevano essere superati. Da allora, l’alpinismo ha continuato a evolversi, mostrando come il coraggio, la preparazione e l’innovazione possano sfidare persino le barriere biologiche più apparentemente insormontabili.
La montagna più alta del mondo
L’Everest domina l’Himalaya a una latitudine di appena 28 gradi nord, quasi allo stesso livello di importanti destinazioni balneari. Nonostante questa posizione relativamente meridionale, le condizioni meteorologiche e altitudinali rendono la montagna uno dei luoghi più ostili della Terra. La maggior parte delle spedizioni moderne si concentra sul versante nepalese, dove il campo base si trova a oltre 5.500 metri di altitudine. Da questo punto, gli scalatori affrontano crepacci profondi, valanghe, venti violenti e temperature che scendono ben sotto i -40 °C.
Caratteristiche geografiche e logistiche
Il percorso verso la vetta presenta sfide differenti a seconda della stagione scelta. La finestra di buone condizioni si apre solitamente tra la prima e la terza settimana di maggio, quando le tempeste di neve sono meno frequenti e il vento rimane generalmente sotto gli 80 km/h. Per scalare in sicurezza, la velocità del vento dovrebbe idealmente restare al di sotto dei 50 km/h. I giorni iniziali del trekking alternano freddo pungente alle prime luci dell’alba con il caldo quasi tropicale di mezzogiorno, una variazione estrema che mette a dura prova il sistema cardiovascolare.
La zona della morte e il collasso fisiologico
Oltre i 7.600 metri circa inizia la cosiddetta zona della morte — l’altitudine dove la concentrazione di ossigeno nell’aria è talmente bassa che il corpo umano non può sostenersi indefinitamente. In questa regione, anche gli scalatori esperti perdono lucidità mentale, il giudizio diventa pericolosamente compromesso e la fatica fisica accelera verso il crollo totale. Gli effetti includono confusione, perdita della capacità decisionale, edema cerebrale e polmonare. Centinaia di persone hanno perso la vita nella zona della morte, sia alpinisti occidentali che guide locali sherpa.
Quando l’impresa era considerata impossibile
Durante la prima metà del Novecento, la comunità scientifica e medica riteneva che nessun essere umano potesse sopravvivere oltre gli 8.500 metri senza supporto artificiale. Questa convinzione era basata su studi fisiologici che sostenevano l’insufficienza dell’ossigenazione naturale a tale altitudine. I primi tentativi di salita riflettevano questa convinzione: ogni spedizione ricorreva a bombole d’ossigeno per aumentare le probabilità di successo.
I primi tentativi e il peso della tradizione
Nel 1951, lo svizzero Raymond Lambert e Tenzing Norgay raggiunsero 8.595 metri, a soli 200 metri dalla vetta — il record mondiale dell’epoca. Nonostante fossero stati supportati da una spedizione ben organizzata e da respiratori, la stanchezza estrema, i viveri scarsi e la qualità inadeguata dei respiratori impedirono loro il passo finale. Tenzing dichiarò in seguito che, anche se fossero riusciti a salire in cima, non sarebbero tornati indietro vivi. Due anni dopo, il 29 maggio 1953, Edmund Hillary e Tenzing Norgay conquistarono la vetta utilizzando ossigeno supplementare, stabilendo il primo successo e consolidando ulteriormente il dogma che l’ossigeno fosse indispensabile per la sopravvivenza in cima.
La barriera mentale dell’ossigeno supplementare
Per due decenni, il ruolo dell’ossigeno artificiale rimase incontestato. Le spedizioni successive hanno ripetuto lo stesso schema: più bombole, più guide, più portatori per trasportare l’equipaggiamento. Tuttavia, negli anni Settanta, un alpinista italiano iniziò a sfidare questa certezza consolidata, sostenendo che l’alpinismo autentico dovesse basarsi su fair means — cioè su responsabilità individuale e pochi mezzi.
La sfida dell’Everest senza ossigeno
Il 8 maggio 1978 accadde ciò che era considerato impossibile e persino letale: due uomini raggiunsero la vetta dell’Everest senza ossigeno supplementare. Reinhold Messner, alpinista italiano, e Peter Habeler, scalatore austriaco, erano parte di una spedizione austriaca guidata da Wolfgang Nairz. Rimangono sulla vetta circa 15 minuti — il tempo di fotografare, girare un breve film e lasciare prove fisiche della loro presenza prima di scendere, ancora vivi e consapevoli.
Messner e Habeler: il salto nel buio
La loro impresa rappresentò il più grande atto di sfida ai limiti dichiarati dalla scienza dell’epoca. Messner ricordò successivamente in un’intervista che gli esperti li chiamavano “pazzi con tendenze suicide”. Con la loro scalata, dimostrarono che la scienza era sbagliata: le ricerche affermavano che oltre gli 8.500 metri fosse impossibile sopravvivere, eppure salirono a quasi 8.900 metri e tornarono al campo base sani e salvi. Questo risultato non era il frutto del caso: Messner rappresentava l’apice dell’innovazione alpinistica moderna, avendo scalato montagne di tutti i continenti, esplorato l’Antartide e il deserto del Gobi.
Come superarono il limite biologico
Messner e Habeler non disponevano di alcun respiratore. Il loro successo si fondò su preparazione fisica straordinaria, acclimatamento graduale e una profonda comprensione fisiologica del corpo umano in altitudine. Nonostante l’aria con solo un terzo dell’ossigeno disponibile al livello del mare, il corpo umano possiede meccanismi di adattamento — in particolare l’aumento della produzione di globuli rossi — che, se opportunamente sviluppati, consentono la sopravvivenza temporanea persino nella zona della morte. La loro impresa validò una teoria alternativa: il corpo umano potesse adattarsi a condizioni estreme se sottoposto a un carico graduale e progressivo.
L’evoluzione dell’alpinismo e le nuove generazioni
Dopo il successo di Messner e Habeler, l’Everest ha continuato ad attrarre scalatori di ogni provenienza. Nel 2022, quasi 44 anni dopo quella storica ascesa, una spedizione composta interamente da scalatori neri e guide nepalesi raggiunse la vetta, segnando un’altra pietra miliare nella storia dell’alpinismo.
Inclusività e diversità sulla montagna più alta
Sette membri della spedizione denominata “Full Circle Everest” conquistarono il Chomolungma — il nome tibetano dell’Everest che significa “Dea madre del mondo” — il 12 maggio 2022. Questo evento riveste importanza storica poiché, dalla prima ascesa nel 1953, solo dieci scalatori neri avevano raggiunto la vetta. L’obiettivo del team non era soltanto personale, ma rappresentava un impegno verso l’inclusività nell’alpinismo, tradizionalmente dominato da esploratori occidentali. Dopo anni di preparazione, il team sperava che il proprio successo ispirasse una nuova generazione di esploratori di ogni provenienza e cambiasse la percezione dell’alpinismo come sport esclusivo.
Il trekking e l’acclimatamento scientifico
La spedizione iniziò in marzo 2022 da Kathmandu, procedendo verso Lukla per poi salire circa 300 metri al giorno attraverso la Valle del Khumbu fino al campo base sud a 5.364 metri. Questa progressione graduale permise l’acclimatamento dei corpi ai bassi livelli di ossigeno. A differenza di altre imprese che cercano il successo rapido, questa scalata enfatizzò il processo metodico di adattamento fisiologico, dimostrando che l’intelligenza alpinistica moderna unisce ambizione personale con rispetto per i limiti biologici reali.
I rischi reali della ricerca del limite umano
Nonostante i progressi tecnici e la migliore comprensione della fisiologia umana, l’Everest rimane mortale. Centinaia di persone hanno perso la vita sulla montagna, e il rischio non diminuisce con l’esperienza, bensì cambia forma. Ogni anno centinaia di scalatori tentano la vetta, ma il successo non è mai garantito e le vittime continuano a verificarsi anche in anni recenti.
La zona della morte e l’inevitabilità del pericolo
La zona della morte rappresenta il compromesso ultimo tra il desiderio umano di esplorare e i vincoli ineluttabili della biologia. Le tempeste possono svilupparsi rapidamente, il vento può salire a velocità letali, e le condizioni di ipossia severa compromettono il giudizio proprio nel momento in cui la lucidità mentale è più preziosa. Anche guide esperte e alpinisti consapevoli dei rischi hanno subito decisioni fatali. La ricerca del limite diventa ossessione, talora letale, e nessuna quantità di preparazione elimina completamente l’elemento del caso.
L’eredità dell’impresa e la riflessione contemporanea
Le imprese che sfidano i limiti umani lasciano un’eredità complessa. Messner e Habeler aprirono una strada, ma ogni passo successivo sulla loro traccia porta con sé sia l’ispirazione che la tragedia. La storia dell’Everest insegna che i limiti umani sono meno rigidi di quanto sembri, tuttavia insegna anche che il prezzo della trasgressione può essere altissimo. L’alpinismo moderno tenta di bilanciare l’ambizione personale con il rispetto per le forze naturali, riconoscendo che la vera conquista non è soltanto raggiungere la vetta, ma tornare a casa vivi per raccontare la propria storia.